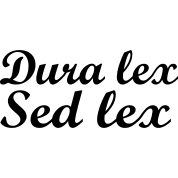di Francesca Santangelo
L’abusivismo della professione rappresenta un fenomeno di allarme sociale sempre maggiore.
Per l’esercizio di determinate professioni (cc.dd. “professioni protette” individuate ai sensi dell’art. 2229 c.c.) la legge richiede il conseguimento di una speciale abilitazione, che attesti che il professionista ha acquisito le competenze tecniche e morali necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale, cui seguirà l’iscrizione all’apposito albo o elenco professionale. L’esercizio di tali professioni che avvenga senza il conseguimento di tale abilitazione è dunque abusivo.
Troppe nuove norme rischiano di essere interpretate in modo vago e solo grazie ad alcune pronunce della Cassazione si riesce ancora ad evitare il superamento dei corretti confini che delimitano le competenze tra le diverse figure impegnate nella stessa branca di interesse. L’abusivismo interessa ogni settore professionale, provoca notevoli squilibri e lesioni di diritti soggettivi, ma è fonte di maggiori danni quando tocca il campo medico, perché l’illecito esercizio di una prestazione medica incide direttamente sulla salute, diritto fondamentale dell’individuo in quanto persona.
Notizie recenti ne testimoniano la gravità del fenomeno. In ambito riabilitativo, recentissima è la denuncia a piede libero fatta ad un fisioterapista che eseguiva attività di anamnesi, diagnosi e prescrizione di accertamenti clinici, di competenza medica. Si tratta, insomma, di un classico (ma ennesimo) caso di abusivo esercizio della professione medica, punito dalla legge penale.
La Corte di cassazione sezione penale, con sentenza n.8885 del 3 marzo 2016 ha confermato che “ciò che rileva ai fini dell’accertamento del reato di esercizio abusivo della professione medica (…) è la natura dell’attività svolta. Ciò che caratterizza l’attività medica, per la quale è necessaria una specifica laurea e una altrettanto specifica abilitazione, è la diagnosi, cioè l’individuazione di un’alterazione organica o di un disturbo funzionale, la profilassi, ossia la prevenzione della malattia e la cura. La legge non consente, quindi, di ritenere lecito l’esercizio di un’attività medica da parte di chi non ha le competenze tecnico-scientifiche formalmente asseverate a seguito del conseguimento dell’abilitazione.
L’esercizio abusivo della professione c.d. protetta è punito ai sensi dell’art. 348 del codice penale.
La punibilità di natura penale si giustifica ovviamente con il fatto che le professioni in oggetto toccano ambiti particolarmente delicati (quale è, appunto, la salute) e per questo motivo lo Stato richiede come condicio sine qua non per il loro esercizio l’obbligo per ogni professionista di possedere requisiti specifici previsti ex lege sia in termini di qualificazione professionale che di possesso di qualità morali e far sì che i destinatari di tali attività professionali (i pazienti) possano vedersi garantito (almeno in via presuntiva) uno standard minimo di competenza professionale.
Proprio per questo nella sentenza della Corte di Cassazione (n.38752/2016) si legge che oggetto di tutela dell’art.348 c.p. è l’interesse generale della P.A. a che determinate professioni, che richiedono particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate solo da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti essere in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge.
Soggetto passivo del reato è, dunque, lo Stato, come soggetto titolare sia del diritto del buon andamento della P.A. sia dell’interesse generale della collettività a vedersi garantito lo svolgimento dell’attività professionale da chi ne ha i requisiti. Oltre allo Stato, però, la possibilità di agire in giudizio è consentita anche ai privati e agli ordini professionali che abbiano subìto un danno indiretto dall’esercizio abusivo della prestazione.
La norma incriminatrice sanziona la condotta di abusivo esercizio della professione posta in essere da “chiunque” eserciti in modo abusivo una professione per la quale è richiesta l’abilitazione dello Stato.
L’art. 348 c.p. rappresenta un tipico esempio di norma penale in bianco, cioè una norma che prevede la sanzione da applicare nel caso di violazione di un determinato precetto ma che richiede la necessaria integrazione di altre norme extrapenali che disciplinino le singole professioni e le condizioni oggettive e soggettive che legittimano l’esercizio di queste ultime. In questo modo, conoscendo le condizioni dettagliate relative alle singole professioni è possibile individuare il confine tra una condotta legittima ed una condotta abusiva.
Di conseguenza, non è abusivo l’esercizio di una professione e non è applicabile la sanzione ex art. 348 c.p. nell’ipotesi in cui una professione non sia disciplinata da una specifica normativa extrapenale di riferimento. Ciò perché la norma penale in bianco ex art. 348 non risulterebbe “completata” dalla normativa specifica.
Per fare degli esempi, stando alle decisioni della Cassazione che si sono susseguite nel tempo, si può affermare che l’esercizio della professione è abusivo quando non sia stata conseguita la relativa abilitazione o per inadempiuta iscrizione all’apposito albo professionale o quando vi sia stata sospensione o interdizione dall’esercizio professionale o decadenza dall’iscrizione all’albo. E non importa se il soggetto abbia eseguito a perfezione l’attività professionale, se questa è stata posta in essere da un soggetto non abilitato.
Perché possa configurarsi il reato di abusivo esercizio della professione ex art. 348 c.p., è necessario ma sufficiente che sia stato compiuto un solo atto tipico o proprio della professione esercitata senza titolo (sent. n.6664/2017), anche se compiuto gratuitamente.
Quanto all’elemento soggettivo del reato, dovrà sussistere il dolo generico, consistente nella volontà del soggetto di compiere l’atto e nella consapevolezza che manchino i requisiti per il legittimo esercizio della professione. Inoltre, il soggetto agente non potrà escludere la propria responsabilità adducendo come causa giustificatrice l’errore sulle norme giuridiche extrapenali (che disciplinano la professione specifica e che integrano la norma penale in bianco ex art. 348 c.p.), perché l’errore su di esse è parificabile all’errore sulla legge penale e non ha valore di scriminante (come nel caso dell’art. 47 c.p.).
Quanto alla pena applicabile, l’abusivo esercizio della professione “diretto” è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10 mila euro a 50 mila euro (comma 1). La pena aumenta (reclusione da un anno a cinque anni e la multa da 15 mila euro a 75 mila euro) quando il delitto è commesso in via “indiretta” e cioè da colui che ha determinato altri a commettere il reato in oggetto oppure ha diretto l’attività esercitata dalle persone che sono concorse nel reato (comma 3).
Ad ogni modo, nell’ipotesi di condanna del responsabile l’art. 348 c.p., al secondo comma, prevede che si disponga la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che erano servite o furono destinate a commettere il reato. Inoltre, qualora il soggetto che abbia commesso il delitto eserciti regolarmente una professione o un’attività, l’art. 348 c.p. dispone anche che la sentenza di condanna sia trasmessa al relativo Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione della sanzione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
f.santangelo84@gmail.com